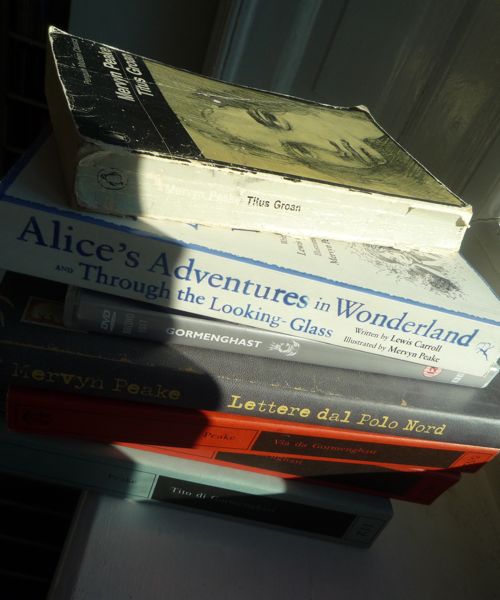va a finire che lo seguo più che altro per motivi musicali: aggiudicatosi incondizionata fiducia negli anni 80 con stop making sense e qualcosa di travolgente (film bello dotato di bella colonna sonora), mi aveva poi deliziato con storefront hitchcock, episodio non secondario nel ritorno di fiamma della carriera di robyn hitchcock a fine anni 90 (poi, come si sa, rh appare anche in manchurian candidate e rachel getting married).
sabato scorso al milano film festival, demme ha detto che riprendere musica dal vivo gli pare la quintessenza del cinema: c'è già qualcosa di appassionante che succede, e non bisogna far altro che coglierlo. così bravo come regista di ogni genere di film (capace di fare suo ogni film di genere), demme è insomma un documentarista nell'anima.
fra i suoi documentari di argomento non musicale avevo già visto the agronomist, e la settimana scorsa ho recuperato il film su jimmy carter, man from plains (colonna sonora di alejandro escovedo), ammirata da come riesce a fare film su brave persone intelligenti e di buona volontà senza cadere nell'enfasi, guidato da una specie di istinto: è molto diretto ma molto preciso, acuto, concede spazio alle emozioni senza sopravvalutarle, racconta efficacemente senza affabulazioni fasulle. viene persino un po' da generalizzare: che meraviglia gli americani, quando sono così. anche nel parlare, stesso stile: spontaneo nell'entusiasmo e gentilissimo, ma concreto, dritto al punto (pur nella strana triangolazione del dibattito al teatro strehler fra le domande vaghe e sgrammaticate della curatrice della rassegna e quelle intellettuali di guadagnino).
per tornare alla musica, approfittando della personale del milano film festival ho scoperto che il primo film di demme, la pellicola di exploitation carceraria (femminile) caged heat, prodotta da roger corman, aveva la colonna sonora di john cale (sempre interessante, e il film non è affatto male – un delirio da cui escono alcuni bei personaggi: peccato vederlo massacrato da una videoproiezione orrenda).
e poi sono andata alla prima del terzo film che jonathan demme dedica a neil young. avevo visto il primo, neil young: heart of gold, ottimo, ma che nella sua ambientazione nashvilliana faticava a conquistarmi completamente.* neil young journeys è molto diverso. doveva chiamarsi neil young life, ma a ny sembrava troppo pomposo. il motivo è subito chiaro: troviamo young nella cittadina dell'infanzia omemee (la quale, diciamolo una volta per tutte, non è in north ontario) che sale su una macchina d'epoca – seguendo il fratello, anche lui su una macchina d'epoca – per andare a toronto, dove terrà un concerto solista alla massey hall, luogo dove notoriamente si esibì con successo nel 1971 (la registrazione è stata pubblicata su disco solo da poco). i ricordi d'infanzia sulle galline dei fratelli young e sulle figlie dei vicini si alternano alle canzoni del concerto, girato con tantissimi primi piani e dettagli del viso, spesso catturati con microcamere montate sul microfono o dentro l'harmonium: qui neil young è vecchio, vecchissimo. forse più vecchio di quel che è in realtà, nel ripercorrere la sua vita attraverso le canzoni (scaletta 2011, scaletta 1971) di nuovo solo su quel palco, solo con i suoi strumenti e una specie di totem indiano. dentro il documentario anche una canzone documentario, ohio, che demme illustra con riprese d'epoca, nomi e ritratti – sapete gli strazianti ritratti da annuario scolastico americano – delle 4 vittime di quando la guardia nazionale sparò a una manifestazione contro la guerra del vietnam. didascalico? no: è per chi non lo sapesse, perché sicuramente tanti non lo sanno – è passato molto tempo. il concerto è bello e jonathan demme segue la sua teoria: lo segue da vicino, ma anche lo lascia scorrere. arriva fino al punto di tenere intera una ripresa della microcamera dove evidentemente l'effetto speciale è… uno sputo del cantante: una chiazza sullo schermo che cambia forma e colore trasfigurando l'immagine – da un incidente meccanico una conseguenza psichedelica – e conservando l'unicità di quel momento su quel palco.
* curiosamente, a causa dell'ambientazione teatrale e della parola prairie tendo a intrecciare il ricordo di quel film – dove young presenta il disco prairie wind – con il quasi contemporaneo ultimo film di altman, radio america (a prairie home companion), nonostante nashville e il minnesota siano piuttosto distanti. sarà che il minnesota confina con l'ontario.